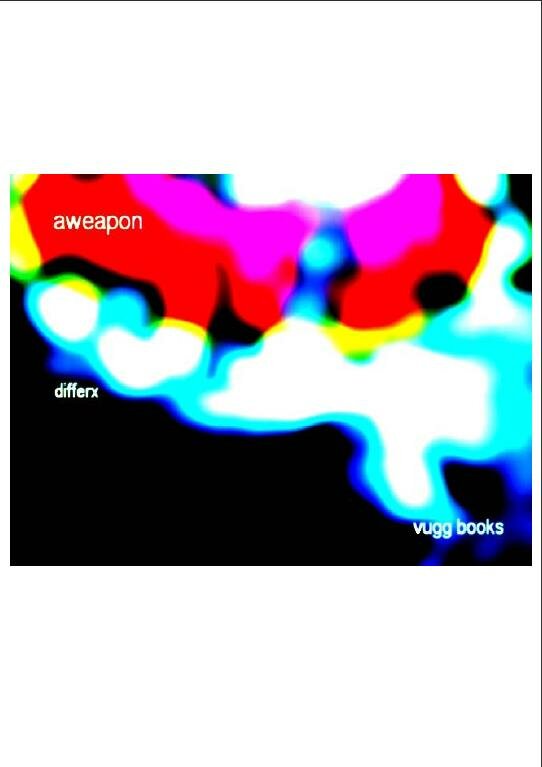|
Verso Buda
Fabiano Alborghetti 2004 Lietocolle |
Il libro di Fabiano Alborghetti ci parla di un viaggio, un piccolo grande viaggio verso il limitare del proprio immaginario, appena oltre il cerchio della città: verso Buda; toponimo che inevitabilmente evoca sconfinate distanze ma che in realtà richiama una collina e una casa nell’Oltrepò Pavese. E’ lo sguardo che lascia Milano, il suo frenetico pulsare, mentre tutto rallenta e il vino “è troppo acerbo/per essere compreso ora,/che ancora è lavoro e filari” pag 15.
Il tempo, quindi, è “il meccanismo complesso di una pendola”, come precisa Fabiano in una nota, “gli accadimenti e la stasi si alternano (…) in centri concentrici e dove al movimento alto-basso prende piede un secondo movimento avanti-indietro tra i rimandi tra presente attivo e l’andata e ritorno”.
Vuoto e pieno: tempo quotidiano – quello della polvere sottile e del rumore – e quello, ancestrale, dove le voci sono presenti e scostanti, ma ricorrenti e precise. In questo tempo ritmo/vuoto il verso cerca una sua faticosa misura, un modo per dire le cose con disciplina, senza ambiguità e senza sciatteria. Si avverte nel libro questo sforzo dello stare in una misura, che è la stessa dei lavori ancestrali, della cura della terra, la quale può essere cantata solamente nell’idea di un suo ordine. In fondo, fecondare è una promessa di ordine.
Così le prove più belle si trovano proprio nei momenti di questa descrizione: “L’uomo che intinge le unghie/nella pazienza intagliata del fare/lo vedo (oltre collina)/cronista dal corpo addormentato/appeso ad un cielo che sa pesare,/che tiene gli occhi aperti/acceso dalla bellezza” pag. 15. Il cittadino si è concentrato nella cronaca; annota, descrive, e così può osservare il trascorrere del tempo, la fatica di un fare mesto, concentrato. Può vedere la bellezza. Questo ci dice che il velo di Maya della nostra epoca è l’affastellamento e l’accumulo, il rumore assordante, le chiazze di verde ritagliate fra i palazzi.
Ritmo del tempo, dunque, scandito dai rintocchi di uno strumento; e tempo nebuloso in cui il prima e il dopo è il volto di una divinità misteriosa. “E’ tutto ancora vivo alla finestra/e non ha perso tempo da quel momento in poi/come se non fosse accaduto niente” pag. 40. E’ lo sforzo di trovare posto alle parole, espresso in un lucido frammento: “Le parole/trovano sempre un posto dove stare:/a volte sopra un foglio, a volte/dentro un cuore” pag. 34.
Se la parola è, come dice Marco Munaro, “ripercorrere rapidamente – in un lampo, miracolosamente chiaro e giusto – la genesi della scrittura dai suoni e dai rumori della realtà fino ai suoni della lingua umana e alla loro trascrizione alfabetica, senza iati”[1], essa dunque si fa depositaria dei ricordi di un viaggio; è l’immagine stessa della terra che ci parla in un alfabeto sensibile. Occorre, poi, conoscere la fatica di chiudere le finestre, e sognare dentro una casa, accanto a una sposa. Questo è il tempo in cui la parola chiede tempo, ci obbliga all’attesa. Ci obbliga alla ricerca di un verso, alla misura dell’andare a capo – operazione decisiva per poter distinguere, dare senso al balbettio quotidiano.