
C’è stato un periodo in cui quelli della mia generazione erano tutti innamorati di Caterina Davinio, non solo della sua bellezza, ma anche della sua estrosità, del suo essere sempre fuori dalle righe, della sua anarchia che si sentiva nei versi, della inquietudine che traboccava e cercava approdi in ogni direzione.
Come lei stessa confessa, Caterina era dentro la letteratura e completamente lontano dalla letteratura e io credo che il suo stare dentro e fuori le ha permesso di percepire gli umori autentici e le energie vere di ciò che intanto le accadeva attorno, in quel mondo paludato e asfittico dei letterati che raramente hanno a che fare con la vita reale, con gli sconvolgimenti in atto nella realtà, con le crisi umane e sociali.
I suoi versi risentono del clima delle varie epoche eppure resistono all’usura del tempo e questo perché hanno saputo cogliere l’essenza dei trapassi, il lievito delle situazioni e dei mutamenti, ma anche perché lei non ha mai messo il velo alle esperienze e ne ha tratto momenti irripetibili.
È una delle rare poetesse che ha attraversato gli ultimi decenni, anche se le poesie del volume datano dal 1971 al 1996, aderendo e rifiutando le esperienze con quel furore necessario per fermare nella parola il miele, spesso amaro, del divenire.
Questo libro non ha una voce unitaria per la semplice ragione che Caterina non ha mai voluto imitare se stessa, ripetersi, riproporre e dilatare i medesimi argomenti e con le medesime espressioni.
Vale la coerenza in poesia? Vale scrivere sempre allo stesso modo dal principio alla fine? Chi lo ha fatto ha annoiato e perfino disperso in un rivolo di abitudini magari qualcosa di importante.
Ma andiamo direttamente ai testi per cercare di capire che cosa innanzi tutto dà carattere a una scrittura così frastagliata. Per prima le tematiche. La poetessa affronta il mondo con piglio deciso e lo contesta e lo rifà a sua immagine e somiglianza, non per narcisismo, ma perché nel riportare a sé ogni cosa riesce a decifrare i segreti della vita, il suo espandersi in direzione della dissolvenza. Non è casuale che ella stessa parli di fiori del male, infatti l’esplicito riferimento a Baudelaire ci fa intendere quanto inferno ha attraversato, quanta angoscia ha vissuto, quanti dilemmi ha dovuto sbrogliare.
Ma lo ha fatto con disinvoltura e non si è sottratta a sperimentare, ad abbracciare immediatamente i sistemi nuovi della comunicazione inserendovi la poesia e quindi portando la stessa in una concezione comparativa che ha sfidato i principi della cronaca con risultati, a vedere i successi ottenuti e gli inviti ricevuti in tutto il mondo, a dir poco encomiabili.
La poesia di Caterina ha lacerazioni profonde, ha ferite, ha resurrezioni, ha cadute nei baratri più neri e ascensioni visionarie che partono, ovviamente, dall’esordio, quel 1971 che ancora sentiva lo strascico subdolo e mortificante di una avanguardia priva di reali necessità e si voleva opporre ripristinando il sogno e l’utopia.
I testi sono presi da cinque volumi che è bene ricordare: Il libro dei sogni (1971-1976), Il libro del disordine (1977-1986), Libro mistico (1987-1989), Libro del caos e del risveglio 1990-1993), Fuori testo (1994-1996) che hanno nel titolo evidente riferimento al libro. Questo è un vezzo che sicuramente viene dalle letture bibliche, perché ho intravisto, e perciò affermo questo, in vari componimenti, bagliori di un’antica saggezza che ha qualcosa di sacrale. Poi c’è anche la dissacrazione e c’è “il mare” che si fa “nero”, e c’è “lei” che “era pane, e io ero niente, / ero cosa che passa” e c’è “La gioia che le ricorda la morte” e infine la presenza di J. L. Borges che “coltivava visioni della sua Buenos Aires”.
La diversità dei metri, dello stile, delle argomentazioni, del ritmo a volte narrativo, a volte acceso da pensieri folti e ispidi, altre volte da pennellate liriche ci accompagnano nella foresta intricata di simboli (cito Baudelaire) nella quale è venuta a trovarsi Caterina che a un certo punto si rende conto di corteggiare “La morte … nel verso”.
Ma Caterina ha sette vite, anzi settanta sette, e lascia a sé le tenaglie in cui le abitudini vorrebbero chiuderla e vola verso altri lidi, sempre, in cerca di una nuova identità, di un approdo che non abbia vecchie incrostazioni e archetipi già sperimentati.
È capace di oscillare tra accenni classici attinti nei testi sacri e nelle opere dei grandi come Hölderlin, il citato Baudelaire, Borges, Artaud e Celan e poi scendere a patti con la Beat Generation, con Ferlinghetti, Corso, con i testi delle canzoni, con pagine della filosofia degli esistenzialisti. Con adesioni immediate, con ripulse, con accensioni vaste e immensi fuochi, con risonanze da musica jazz e pop.
Il magma in Caterina prende però la sua voce e anche quando, per esempio, tutti i versi di una poesia cominciano con la D, ella fa sentire le variazioni e le vibrazioni della sua anima inquieta che non si placa e che, ne sono certo, continuerà a cercare il senso del vivere, la via che porta a una luce nuova e diversa.
E se non esistesse, questa via?
Sarà valsa la pena del viaggio, perché Caterina è nel viaggio incessante che ha trovato il senso dell’essere e del divenire.
*
Scrivo due righe sghembe
e poi vado a vomitare
la punta della matita si spezza
perché calco sul foglio
come scolpissi la pietra,
ed è il mio primo verso,
la prima sbronza con mio padre,
il primo foglietto di carta
al vento.
Prosit!
*
Droga
Volevi provare,
mia giudiziosa amica,
e andammo in quei meandri
del parco
dove più sentivamo l’ebbrezza
del rifiuto,
delle scelte ascose,
e lui, più esperto,
ci raggiunse
con un sorriso d’intesa sotto i baffi
e il volto smunto.
Tu volevi per gioco, e io per davvero,
ti presi alla lettera e capii
che da tempo aspettavo
d’incrociare quel pomeriggio;
non chiedere perché
fu la strada facile
e più mai tornai
mentre tu ti ritraevi prudente
salutandomi con la mano dal ciglio
delle fragole e del vento,
risucchiata dalla lontananza.
Fu l’inizio
in cui imparai
a precipitare nel nulla
che ancora mi morde,
da quell’aereo giorno nell’oscuro del parco,
di vortici,
buchi neri,
di sdrucciolosi sentieri.
1976
*
Al Piper con Chiara, la mia amica
Al Piper rocambolava la notte
di corpi mossi nell’euforia della danza
lei, la mia amica, era depressa
ella vedeva lungo sul proprio disamore
di spacciatrice tenera,
di lesbica chiusa alle speranze,
desiderosa di veleno.
Nel carambolare del night
tra il rumore assordante
volle un gesto seduttivo per il non amore:
mi regalò un pezzo di fumo
tra due dita
come un fiore,
e poi mise la sua lingua nella mia bocca
mostrandomi quanto può essere dolce
la sponda amara,
e io risposi con la mia lingua
che sapeva il rapimento della notte,
di quei suoni che andavano
a rotta di collo per condurti
agli inferi più dolci.
Fu il momento più bello con la mia amica,
un’icona dell’essere perduti,
andati,
e senza rimorsi né
aspettative per questo futuro avaro di note.
Lei era bella come un uomo
con bicipiti e tatuaggi sfrontati,
lei sapeva farti nascere
la voglia di camminare lungo l’asse d’equilibrio
sul baratro di un mondo perso e scostante, nemico,
lei viveva spericolatamente l’ora, e ti trascinava
nel suo abisso così tenero,
tanto che m’innamorai e presi dell’ora il momento,
le dissi che essere amanti era il progetto
di me incapace di fedeltà
con i ragazzi,
ammalata di siringa e di linee,
d’esperienza, di veleni,
vogliosa di voluttà antica, senza nome.
Ciao, amica mia,
serbo il tuo ricordo
in una fotografia del cuore
che nulla dimentica se non momentaneamente:
finì la notte al Piper
e fummo di nuovo amiche
che nella strada andavano
fianco a fianco
cadendo ad ogni passo verso il perdono,
crollando dove colpisce l’eterno
i nostri passi precari sulla terra.
1985
*
La casa di Chiara
Accovacciata sulla moquette di casa tua, amica mia,
ogni pomeriggio nel caldo delle due
sorseggio una birra
e aspetto i miei segnali proibiti:
droga, fiacche iperboli accatastate
nel piccolo universo che mi spazia (strazia) intorno
come un fratello,
in una nube d’amicizia arriva la catastrofe.
In fondo bucarsi una vena è atto concreto
ed efferato,
colano rivoli, sprizzano nell’ago,
ti dicono di desistere,
ma caddi in un barile di carezze e amore
calore e ottimismo,
la droga mi abbracciò,
spesi il tempo sulla tua moquette
davanti alla televisione
e una birra maledetta di circostanze;
tu, amica, non temevi e io ti imitai
sulla strada
di pericoloso gaudente,
di gaudente suicida,
di perigliosa rincorsa
a fortune
alterne
scacchiere temerarie.
E me ne vado delusa e contenta nel pomeriggio,
con il mio sale e pepe nelle vene, con l’ebbrezza nella testa
grata a dio e ai demoni
che imperversano su questa città,
in fondo felice dei miei tremendi errori,
disegnavo traiettorie sbagliate, e tutto era errore
predestinato,
me ne ridevo e amavo andare
di traverso, sbilenca
alla rovescia
sbagliata,
a scovare sacrilegi nelle giornate spente
per ravvivarle, non accenderle,
ché sarebbe impossibile dare fuoco
alla morte
annidata nelle pieghe
di giorni atroci e inermi
placidi di stupore,
di luce, di noia come una falce,
mortali di quiete;
sperperai tutto e alla fine
fu niente:
le nostalgie dell’errore,
la fame mortale dell’errore,
la resa all’errore,
che mai risorse dalla culla del baratro,
e amò morire in una stazione
di viaggiatori scagliati verso ultime mete.
*
Festa notturna in un casale di campagna
Quella notte la terra tremò,
quaranta scosse e più,
mentre andava la musica tra le vecchie mura
e i folli danzarono,
torsero le loro bocche
nel riso selvaggio,
vuotarono i bicchieri di vino rosso.
Il mio amico scappò fuori, nel bosco,
aprì le portiere dell’auto, accese lo stereo
e spaccò la notte con i suoni
del suo rock più cattivo,
poi si mise a rollare marijuana
e io, già ubriaca,
vidi il mondo andarsene sghembo, di traverso,
travolta da una vertigine e da un conato,
partii per la tangente verso l’infinito,
su per soffitti ebbri
che vorticavano
emulando l’alto dei cieli.
Poi la notte andò oltre
e finimmo addormentati negli angoli
di quelle grandi stanze di pietra,
il gelo ci morse
quando restarono solo i sassi del focolare
a insinuarsi nel buio
con bagliori rossi di legna arsa
morenti nella lunghissima notte artica.
Mi accovacciai su quelle lapidi ancora tiepide,
sofferente,
e mi strinsi nella pelliccia ispida
come un vecchio esploratore
in un cantuccio di boschi d’Alaska,
selvatica, come una vecchia orsa.
Nel mantello di ruvidi peli
come un gatto opportunista.
Mentre la terra tremò,
quaranta scosse e più,
la nostra notte sghemba
piano svanì nell’alba spettrale.
Eravamo rimasti in pochi
e un ricordo il fragore notturno
di rocambolesco rock’n’roll,
e andammo intorno
smilzi nelle nostre smorfie gay,
colorati nel grigio
come grida d’angoscia.
*
La mia famiglia
Eravamo troppo poveri
troppo da essere arrabbiati l’un l’altro
i nostri figli dei nemici feroci
tu opportunista tenace
io in fuga,
la nostra famiglia era un cappio
mortale,
non so come potemmo crescere, sopravvivere,
in quei meandri di rabbia
che fiorivano sull’amore
come una pianta velenosa,
ma tra il disordine,
il dispetto, l’incuria
continuarono a nascere fiori abnormi,
gli insetti brulicarono di vita,
io sola ne ebbi raccapriccio
mentre tu spaccavi tutte le cose
e i nostri bambini ribaltavano la casa
invasi come demoni.
Vedi in una lente sbagliata, dissero.
E io penai a ricostruire il mio mondo
da quelle macerie.
A tenermi in piedi come un soldato
nella sporcizia
incurante del lavoro,
dell’amore.
Vedi, la parola amore ci disorienta
perché sembra tenera
invece è fatta di solitudine e di fiele,
di ossa spezzate e di sarcasmo,
eppure nella nostra gabbia di stenti
e arroganza
l’amore c’era ad aggrapparci gli uni agli altri
come erba gramigna,
come rampicanti selvaggi
che insidiano le mura antiche della casa.
Fratello mio, il nostro cuore
era cattivo,
i nostri sogni libertari e fuggevoli,
non è facile scoprire come essere felici
alla gogna, con la gola stretta
tra assi spietate,
ma abbi fede nel tempo.
1989
*
Quando fu buio andammo ai campi,
su, per il sentiero sdrucciolando
protetti dal morso della serpe da robusti stivali
Agguerriti e sfiniti dalla disubbidienza
schegge e colori ci schernirono
nell’apparente scemare del giorno
sul monte saccheggiato
sullo scosceso dirupo, con radici attorcigliate
dove andammo su per mirare gli elfi
e il vento sbaragliò le nostre armate
la notte s’appiattì sull’orizzonte
il nero della notte s’inabissò nelle anime
e grande spazio vi schiuse
con dissolvenza e inadempiuti travestimenti
innalzandosi sopra il dirupo
sopra il dirupo impervio dove il fiore s’affaccia
nel suo solo giorno di vita a gettare
il polline, come un piccolo occhio
subito rintuzzato dall’infinito.
*
L’Absinthe
Artificieri nel teatro dell’assenzio
filosofia di amori impazienti
magniloquenza di curiali nellferemo
nel feretro tutti delle città.
Alla maniera mediterranea, la grande sera
sui frangiflutti sferza schiuma
strati alti rasenta d’atmosfera.
Si scommette e facezie ai crocevia:
secondini, pittori e caparbi
gendarmi,
tutti nella fiaschetteria dellfassenzio.
Gradazione oscura e fluorescenza, sulla vetrina
rivoli, dietro ai tavoli dove brulica il grigio
per le strade si aggirano nocchieri,
zanzariere intravedendo d’infinito
nel velluto dei vinai.
Bische e bracieri
confortati dal balbettio di parole
consumano lfadulterio di biancospini.
E Dio che ha fabbricato la ruggine
divincolandosi dalla storia
con sperpero di venti la disperde
tra i sorrisi schivi dellfuniverso indeciso.
1990
*
Psicofarmaci
Mi guariscono
strappando le mie membra al buio
fino a lacerarle,
vogliono
uccidere i miei demoni,
quei fratelli assassini
delle mie giornate.
Vado sull’orlo del ciglione
che si spalanca alla caduta,
la mente dispersa e spaventata,
la mia generazione corrotta,
contaminata,
degenerata,
e sono stanca di giochi,
di sbronze,
di ragazzi perduti
come angeli,
di notti allegre.
Così il male si precipita infine su di me
e mi trascina a fondo,
nelle nostre case segrete,
dove lui dormiente
è oggi risvegliato
come un guerriero distruttore:
domina,
e io sono umiliata.
Cosa mai la mente?
Io sopravvissi ai tempi dell’eroina:
l’oppio mi curava l’anima rotta di etilista
e l’alcol i disordini dell’oppio,
mezzanotte per impadronirmi come un teppista
della città,
e adesso preda di un male cruento e astemio:
formule chimiche
scandiscono il tempo,
sono la cura,
mi salvano dalla vita.
1989




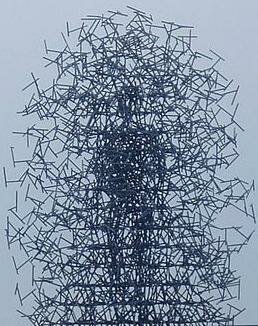
Ringrazio tanto Dante Maffia.