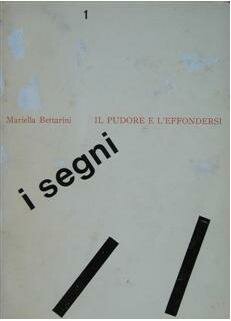di Emanuele Trevi
Quello che vediamo è un fuoco di sterpaglia, una tazza scheggiata, la mappa dai bordi bruciati. Beppe Salvia non raggiunse a caso una semplicità così radicale.
Egli fronteggiò con coraggio gli spettri novecenteschi: surrealismo, angiolismo, gigionismo, tecnicismo. Il ritorno al futuro dev’essere stato lancinante.
Eraldo Affinati
 Ho trovato un lavoro, racconta Beppe Salvia in una delle sue ultime poesie, e adesso “sono rispettato”. Alla fine possiedo anch’io, prosegue il poeta, un mio “leggero confine”: ciò che mi rende possibile stare al mondo, visto che il mondo “non si può fuggire”. Ma ecco che la poesia, affermato in tono così euforico e sincero l’avvenuta acquisizione di un pur minimo principio di realtà, immediatamente smentisce se stessa, afferma il contrario di ciò che aveva appena detto. “Ma io”, dice infatti Salvia, “ho nostalgia / delle cose impossibili, voglio tornare / indietro.” Questo affermare e smentire, questo procedere andando a ritroso, è qualcosa di più del contenuto di una singola poesia. Per Salvia, sembra trattarsi proprio di una regola generale: nello stesso tempo un’idea di discorso poetico e una forma di esistenza. Nato a Potenza nel 1954, e morto a Roma il 6 aprile del 1985, Beppe Salvia ha letteralmente bruciato le tappe, lasciandosi alle spalle alcune delle più belle poesie liriche del secondo Novecento. Questo percorso fulmineo, però, ha tutta l’aria di un ritorno all’origine, va avanti ma solo a patto di alludere a un inizio, a una luce sorgiva, a un oriente. Ha insomma tutte le caratteristiche di un doppio movimento e dunque, in definitiva, di un falso movimento. Più le prospettive diventano cupe e il peso di vivere si aggrava, del resto, più i versi si fanno limpidi di dettato e armoniosi di ritmo. È una delle risorse (forse la più estrema, e decisiva) di questo moto intimamente contraddittorio, di questo procedere a ritroso alimentato dalla nostalgia dell’impossibile. Non c’è bisogno di aggiungere che la risorsa non implica una particolare forma di salvezza o di riscatto, anzi è totalmente inscritta in una tragedia individuale. Esiste dunque una saggezza che, senza per questo cessare di essere pura e profonda, è del tutto estranea alla felicità, non deriva dal cavarsela in qualche modo, non implica un rinnovato patto col mondo. “Sono felice e triste”, scrive Salvia in un’altra poesia, come a voler dichiarare: io rimango conficcato in un’antitesi, come l’uomo orfico di Rilke, e nessuna dialettica, nessuna immagine di salvezza, nessuna superiore ricomposizione delle lacerazioni mi porterà via di lì. È la stessa saggezza, se di saggezza è ancora lecito discorrere, che riconosciamo negli ultimi versi di Sylvia Plath, o di Amelia Rosselli.
Ho trovato un lavoro, racconta Beppe Salvia in una delle sue ultime poesie, e adesso “sono rispettato”. Alla fine possiedo anch’io, prosegue il poeta, un mio “leggero confine”: ciò che mi rende possibile stare al mondo, visto che il mondo “non si può fuggire”. Ma ecco che la poesia, affermato in tono così euforico e sincero l’avvenuta acquisizione di un pur minimo principio di realtà, immediatamente smentisce se stessa, afferma il contrario di ciò che aveva appena detto. “Ma io”, dice infatti Salvia, “ho nostalgia / delle cose impossibili, voglio tornare / indietro.” Questo affermare e smentire, questo procedere andando a ritroso, è qualcosa di più del contenuto di una singola poesia. Per Salvia, sembra trattarsi proprio di una regola generale: nello stesso tempo un’idea di discorso poetico e una forma di esistenza. Nato a Potenza nel 1954, e morto a Roma il 6 aprile del 1985, Beppe Salvia ha letteralmente bruciato le tappe, lasciandosi alle spalle alcune delle più belle poesie liriche del secondo Novecento. Questo percorso fulmineo, però, ha tutta l’aria di un ritorno all’origine, va avanti ma solo a patto di alludere a un inizio, a una luce sorgiva, a un oriente. Ha insomma tutte le caratteristiche di un doppio movimento e dunque, in definitiva, di un falso movimento. Più le prospettive diventano cupe e il peso di vivere si aggrava, del resto, più i versi si fanno limpidi di dettato e armoniosi di ritmo. È una delle risorse (forse la più estrema, e decisiva) di questo moto intimamente contraddittorio, di questo procedere a ritroso alimentato dalla nostalgia dell’impossibile. Non c’è bisogno di aggiungere che la risorsa non implica una particolare forma di salvezza o di riscatto, anzi è totalmente inscritta in una tragedia individuale. Esiste dunque una saggezza che, senza per questo cessare di essere pura e profonda, è del tutto estranea alla felicità, non deriva dal cavarsela in qualche modo, non implica un rinnovato patto col mondo. “Sono felice e triste”, scrive Salvia in un’altra poesia, come a voler dichiarare: io rimango conficcato in un’antitesi, come l’uomo orfico di Rilke, e nessuna dialettica, nessuna immagine di salvezza, nessuna superiore ricomposizione delle lacerazioni mi porterà via di lì. È la stessa saggezza, se di saggezza è ancora lecito discorrere, che riconosciamo negli ultimi versi di Sylvia Plath, o di Amelia Rosselli.
Ma chi è stato, Beppe Salvia? Al di là, o se si preferisce a fianco della grandezza poetica, è rimasta attaccata al suo nome una tenace leggenda personale, alimentata dagli amici romani e poi accolta, assieme all’opera, da tanti lettori (anche giovanissimi) che non hanno mai potuto conoscerlo. I lettori di poesia, come si sa, sono capaci di nutrire forme incondizionate di fedeltà, immedesimazione, proiezione simbolica, alle quali forse nessun romanziere potrebbe mai aspirare. Da questo punto di vista, l’esiguità quasi irrisoria delle tirature e la quasi totale assenza di altre forme di prestigio sociale non deve trarre in inganno. In realtà, il tipo di successo che può toccare in sorte a un poeta è il più difficile da conseguire, ed anche il più efficace e duraturo. Indubbiamente, la tappa iniziale di questa leggenda o mito personale di Salvia va riconosciuta nella pagina culturale del “Paese Sera” del 18 aprile 1985. A pochi giorni dalla morte di Salvia, lo ricordano con intensità e commozione tre amici, tre compagni di strada concordi nel denunciare la gravità della perdita. Viene in mente ciò che scriveva Roman Jakobson all’inizio del suo grande saggio su Majakovskij, composto poche settimane dopo la morte dell’amico e maesrro: “Il dolore dell’assenza adombra l’assente. Adesso è più penoso, ma più facile scrivere non di ciò che è stato perduto, sebbene della perdita e di chi ha perso”. Su un punto, le testimonianze di Edoardo Albinati, Arnaldo Colasanti e Marco Lodoli sono assolutamente concordi: Salvia è stato uno di quegli uomini, rarissimi se non unici, in possesso di un autentico carisma. Un’aura, se si preferisce, che è generata certamente dal fascino dell’opera, ma che, nello stesso tempo, dell’opera è anche la premessa, il senso più profondo. In quello stesso 1985, Gabrieila Sica pubblica Estate, la prima raccolta poetica di Salvia, a firma di Elisa Sansovino. Ha inizio dunque anche il cammino editoriale, tutto postumo, dell’opera poetica. Ma un carisma, se è tale, precede sempre ogni forma di consacrazione postuma. Non ha bisogno di libri pubblicati, e tantomeno di riconoscimenti critici ufficiali. La grandezza di Salvia, in altre parole, era già un fatto acquisito, per chiunque leggesse riviste come “Braci”, “Prato pagano”, “Nuovi Argomenti” o semplicemenre ascoltasse il poeta in una lettura pubblica, delle tantissime che si organizzavano in quegli anni. Salvia insomma è stato tutto il contrario di uno scrittore interamente “scoperto” dopo la morte, alla maniera, mettiamo, di un Guido Morselli. La sua fama si è allargata quantitativamente, grazie soprattutto alle edizioni postume, ma senza alterare nella sostanza una fisionomia originaria già definita durante il corso della sua breve vita. Salvia poteva essere il più nuovo, il più inesperto dei poeti, e guardare a se stesso come a chi ha ancora tutto da imparare, tutto da sbagliare. Ma nei fatti, quando scrive, pur senza dimenticare l’inesperienza e i tentativi a vuoto, si comporta come un classico.
Se insisto su questo argomento della “leggenda”, è perché un mito personale genera sempre un paradosso: nel momento stesso in cui garantisce e rafforza la sopravvivenza di una data memoria, sfuma e rende irriconoscibile proprio il suo oggetto. All’inizio dell’Inferno Dante definisce con un aggettivo, tanto preciso da risultare terribile, il progressivo sfibrarsi e decomporsi dell’immagine del morto. Lo fa raccontando il primo incontro con lo spettro di Virgilio, che a causa del “lungo silenzio” della morte, è percepito come fioco. L’aggettivo si riferisce primariamente, come nell’italiano di oggi, alla sfera dell’udito, e cade a proposito parlando di “silenzio”, ma c’è qualcosa di più, una specie di geniale e fulminea sinestesia, che coinvolge anche lo sguardo e la difficoltà di guardare un oggetto che sembra tremare nella lontananza, o far emergere a fatica dal buio i suoi contorni. Ecco, nel corso degli anni anche l’immagine, l’ombra di Beppe Salvia, mi è sembrata diventare via via più fioca. Bene, si dirà: può capitare, è un normale effetto del tempo, ed è a tutto vantaggio dei versi, della loro bellezza e potenza emotiva. Che ne sappiamo, in definitiva, di un lirico greco? Che tipi erano Ibico e Anacreonte? Che pensavano, di che soffrivano davvero? Questo punto di vista è insieme esatto e inesatto. È vero che il testo poetico è qualcosa che ha il suo valore in sé, e quasi ostenta una libertà di senso che è anche libertà da ogni costrizione e determinazione. Ma è altrettanto innegabile che la poesia, tra tutti i generi letterari, è il più biografico, se così si può dire – anche più del diario, della lettera, della confessione… Perché un’opera in versi non fa che suggerire un ritratto, non si stanca di alludere a un’immagine, possibile o impossibile che sia, della vita individuale, di quella concreta e irripetibile esistenza in cui mette le radici e cresce la poesia. Tempo, memoria e destino sono sempre i suoi ingredienti essenziali, e la loro eventuale negazione ha lo stesso significato, finisce comunque per cooperare a un’idea dell’esistenza. È il motivo per cui, mentre lavoravo a questa edizione, più volte ho scrutato a lungo, come se potessero farsi sfuggire un qualche tipo di suggerimento inatteso, le vecchie foto in bianco e nero di Beppe che mi capitava di ritrovare sulle riviste o su sbiaditi ritagli di giornale. Anche se, come spesso accade, l’aiuto più importante mi è arrivato da qualcosa che non c’entrava affatto. Si tratta di un’opera abbastanza famosa di Andrea Pazienza, un ritratto di Tom Waits del 1986. Il giovane artista che fuma una sigaretta (o uno spinello, come sembra suggerire la densità del fumo) di fronte alla tastiera muta potrebbe in realtà essere lo stesso Pazienza, o magari Salvia… Contraddicendo la più elementare regola del ritratto, Pazienza infatti copre interamente i lineamenti del profilo di “Tom Waits” (le virgolette si impongono) con il dorso della mano, consentendo identificazioni e slittamenti molteplici e incontrollabili. Il giovane è di bell’aspetto, con il fisico asciutto e le spalle larghe. Ma è quel tipo di tonicità paradossale che convive più con i vizi che con l’esercizio fisico, e ricorda il ritornello della canzone di Carboni – ci vuole un fisico bestiale per bere e per fumare… Sulla spalla sinistra del giovane artista, che ha le palpebre socchiuse e la testa inclinata in avanti, c’è un buffo uccellaccio, una cornacchia che tiene nel lungo becco (questa volta non ci sono dubbi) una canna, mezza fumata e spenta. Questa cornacchia è disegnata in uno stile diverso dal resto del ritratto, – impostato su un registro di minuzioso ed elegante realismo. È buffa, certamente proviene dal mondo dei cartoon. Ma come si sa, i cartoon non sono mai solo buffi. A certe ore della notte, o se si preferisce a certi gradi di smarrimento, di lontananza dal mondo, di pura e semplice alterazione da alcol o da droghe, la presenza di un cartoon sulla propria spalla non prelude a niente di buono. Nell’animale non c’è nulla di protettivo, di totemico, di beneaugurante. I suoi tratti comici sembrano esprimere cinismo, o sarcasmo. Eppure, il giovane artista e la sua cornacchia sono un insieme solidale: l’uno non ci sarebbe senza l’altra. Questa più vasta possibilità di senso è data dal rapporto tra l’individuo e qualcosa che gli appartiene, pur non essendo lui: possiamo definirlo il dèmone. Il dèmone ha innumerevoli forme e innumerevoli qualità, a seconda degli individui e dei casi della vita. Appoggiata sulla spalla del giovane artista di Pazienza, la cornacchia potrebbe rappresentare la sua paranoia, oppure il suo talento. Meglio ancora, entrambi: come se la paranoia e il talento fossero solo due aspetti, due temperature della stessa sostanza psichica.
Beppe amava queste finzioni. In molti esultammo quando su “L’oca parlante”, una piccola rivista romana, leggemmo due poesie di una certa Silvia Isola, nata a Città di Castello nel 1962. Una voce nuova, un verso leggero e tremante. Poi scoprimmo che era sempre Beppe.
Marco Lodoli
Di immagini dirette o metafore del talento, del resto, l’opera di Beppe Salvia è letteralmente satura. Come in Andrea Pazienza, così in quest’altro grande virtuoso che è stato Salvia il talento non è un semplice dato di partenza, una premessa stabilita una volta per tutte, ma finisce sempre per invadere lo spazio stesso della rappresentazione. È la storia del talento, la storia dell’avere un talento che ci viene insomma raccontata senza tregua da questi due artisti a combustione rapida, come da altre vittime precoci di quei tempi: la grande fotografa Francesca Woodman, per esempio, che lavorò tra Roma e New York e che si è uccisa quando era ancora così giovane che a stento si riesce a credere che si sia lasciata dietro un’opera così ricca, varia, emozionante. Il fatto è che il talento tende alla sovrabbondanza, moltiplica le sue prove fin dove e quando è possibile. In Estate, il suo primo libro uscito nel 1985, Salvia trova un’immagine perfetta, parlando del “sottile fischio” che, a saperci fare, si produce passando il dito sull’orlo di un bicchiere di cristallo bagnato. Ma la coppia di endecasillabi memorabili che racchiude il concetto non si limita a enunciare un’idea: i versi sono essi stessi, nel loro vertiginoso virtuosismo, un esempio di talento in atto, come la mano del celebre disegno di Escher che disegna se stessa nell’atto di disegnare: “tinna un sottile fischio se lo bagno / e in circolo col dito tocco l’orlo”. Dal cristallo della lingua, di per sé inerte, il dito del poeta dovrà tirare fuori questo suono “sottile” e nella sua sottigliezza prezioso, inimitabile. Dovrà trovare un difficile e incerto equilibrio tra delicatezza e decisione. Alla fine, la resistenza del mezzo viene completamente vinta, e le parole sembrano ballare in perfetta sincronia sul filo del ritmo: “colori mal composti nel disegno / il segno somigliano d’un sogno”. È intorno a questo tipo di risultati, intimamente memorabili, che tra l’altro si iniziò a formare la famosa leggenda di Salvia. Che sui suoi amici come su una più vasta cerchia di poeti e lettori di poesie dei primi anni Ottanta, esercitò il fascino, spinto fino al limite del ricatto psicologico, tipico del più bravo, di chi conosce tutti i trucchi, di chi è in grado di fare tutto – di farlo tintinnare davvero, una buona volta, quel dannato bicchiere umido. Ma dell’idea del fischio prodotto dal cristallo bisognerà anche ricordare che, a produrlo, Salvia sta immaginando delle dita femminili, di ragazza. Estate esce a nome di una certa Elisa Sansovino, e Beppe Salvia vi figura solo come il curatore della ristampa di un’esile raccolta di versi uscita molto rempo prima, nel 1949, “per i tipi dell’editore Sanesi in Roma”. La soperchieria è talmente spudorata da risultare credibile ed effìcace. Un critico molto acuto e sensibile, Roberto Galaverni, ritiene che la scelta dello pseudonimo femminile per questo esordio sia dovuta al “pudore e la gentilezza peculiari di Salvia”. Salvia indubbiamente, tra le tante altre cose che era, era pudico e gentile, ma Elisa Sansovino, più che uno pseudonimo, è un eteronimo nel senso di Pessoa, e gli eteronimi non sono mai innocenti, come invece possono essere, e volentieri sono, gli pseudonimi. Nella biblioteca di Salvia (la notizia mi viene direttamente dal fratello Rocco) era presente l’edizione italiana delle poesie di Pessoa, che il curatore, Antonio Tabucchi, ha intitolato Una sola moltitudine. Non diversamente dal grande portoghese, Salvia coltivò il gusto, o la tentazione, dell’eteronimo. Specie al femminile: ricordo solo, accanto a Elisa Sansovino, la fugace apparizione in rivista della “leopardiana” Silvia Isola. Gli eteronimi, in quella perpetua mitobiografia che è la vita di un poeta, incarnano un principio di dissociazione che è prossimo alla schizofrenia. Possono assomigliare a un gioco, ma sono sempre un sintomo. In Elisa Sansovino tutto ciò si unisce anche con una pulsione al travestimento, al travestimento in panni femminili. Il tempo e i luoghi sono quelli di una lunghissima vacanza estiva, in una casa amata e familiare, una grande casa mediterranea piena di memorie e vicina al mare. È un tempo felice ma non infinito, e la conclusione della raccolta racconta mestamente proprio il ritorno in città, alle prime piogge che annunciano l’autunno. Ma il libretto non finisce lì, ci sono anche, in una breve appendice, una foto di Elisa vestita di bianco, seduta su una Lambretta assieme alle amiche del cuore, e un’ultima poesia, in corsivo, che andrà attribuita a Beppe Salvia, il curatore della raccolta di Elisa. Qual è il senso di questo travestimento? Perché insomma Estate, il primo libro di Salvia e l’unico interamente rivisto e licenziato per la pubblicazione dall’autore stesso, si presenta come la ristampa di un vecchio e dimenticato libro scritto da una ragazzina in vacanza? Io credo che Salvia, con questa invenzione di Elisa Sansovino, abbia voluto dar forma a un’intuizione fondamentale del suo percorso artistico. Non è un idea del femminile in sé che gli interessa di rappresentare con la sua falsificazione, con la sua proiezione in quella ragazza del dopoguerra. È un’idea del poetico che Salvia cerca in fondo alla sua evocazione del femminile. L’identità del femminile e del poetico a sua volta sembra rimandare a qualcosa di ulteriormente profondo, e non più nominabile. È una specie di smania, la percezione di un vuoto che nulla e nessuno riusciranno mai a riempire, un vuoto centrale, il centro vuoto dell’immagine di sé. Ma è anche un suono, o meglio la ricerca di un particolare suono del mondo e della lingua, la disposizione ad ascoltarlo. Prima ancora che l’artefice e il padrone dell’espressione, pensa Salvia, il poeta è un individuo eminentemente ricettivo. E se il percepire, forse ancora più dell’esprimere, è da considerarsi la sua esperienza decisiva e la sua avventura suprema, ciò significa che egli paga alla femmina, alla femmina che sta dentro di lui, il tributo più alto possibile. Per quanto salda e prepotente potrà essere la sua parte virile, il femminile finirà sempre per spuntarla, per dettare i tempi delle emozioni e delle percezioni. La sua ombra, l’ombra di Elisa, si proietta su tutti gli scarti e gli snodi decisivi del divenire poetico di Salvia.
È sempre difficile stabilire come e in che misura un “clima” condiziona l’opera di un singolo. Esiste per esempio la storia della poesia, che descrive e motiva le genealogie, le parentele, le soluzioni di continuità. Senza nulla perdere della sua singolarità l’opera di un poeta, all’interno di questo tipo di ricostruzione critica, può essere interpretata in un suo possibile contesto: come quando parliamo di poesia simbolista, o dadaista, o ermetica… Ora, è ovvio che la poesia di Salvia non nasce dal nulla. Il tratto “culturale” più evidente della sua poesia, per esempio, che è la necessità di studiare e recuperare le forme della tradizione lirica, magari sottoponendole a frammentazioni e torsioni manieristiche, è condiviso da molti poeti suoi coetanei, e riempie di sé riviste come “Braci” e “Prato Pagano”. Non si tratta solo del recupero di schemi formali come il sonetto, o delle sperimentazioni anche molto ardite sulla rima. È soprattutto il discorso lirico in quanto tale, a mio parere, ad affascinare Salvia e molti suoi amici. E un tipo di enunciazione molto complesso, che non arretra di fronte a nessuna arditezza sintattica, e fondamentalmente si basa su un conflitto tra le unità metriche (i versi) e le unità del pensiero (le frasi attraverso cui procede il discorso). Da Petrarca a Leopardi (passando per Tasso), questa è la via maestra della lirica italiana di tono “elevato”. Non è un caso che il bagaglio culturale implicito nella poesia di Salvia sia stato colto perfettamente da poeti che partecipavano, ognuno a suo modo, agli stessi entusiasmi e alle stesse avventure. Penso allo studio – quasi esasperante per il suo tecnicismo – che Pietro Tripodo ha dedicato alla metrica di Salvia. O all’orecchio finissimo di Gino Scartaghiande, che ha individuato nel Sentimento del tempo di Ungaretti il modello più ispiratore e vincolante per la formazione del giovane poeta (per parte sua, Gabriella Sica ritiene invece decisiva l’influenza della “scienza del cuore” di Petrarca). Eppure, se volessimo riferirci, come accennavo sopra, alla storia della poesia italiana, poco soccorso ce ne verrebbe. La mia sensazione è che non solo Salvia, ma anche tutti i suoi amici siano arrivati fuori tempo massimo – non dopo una presunta morte della poesia, voglio dire, ma dopo la morte della storia della poesia. Basta sfogliare le riviste del tempo, e non solo quelle romane, per rendersene conto: come l’anguilla di Montale, questi poeti risalgono alle polle sorgive della tradizione, spinti da amore e disperazione. Ma il loro gesto non implica né una posizione, né un fondamento finalmente ritrovati. Una cosa, infatti, è riannodare i fili dorati della tradizione e ricollegarsi ad essa (come fanno Ungaretti o Saba o ancora Penna) quando si tratta ancora di qualcosa di vivo, che contiene un futuro potenziale. Ben altra attitudine esprime chi, come Salvia e Tripodo e tanti altri poeti loro coetanei, non si muove più al riparo di un’istituzione di senso, all’interno di un tessuto di convenzioni che assicuri ai suoi gesti una piena leggibilità. Ogni poesia di Salvia semmai ha l’aria di ricominciare tutto daccapo, o meglio di inventare le regole del gioco via via che esso viene giocato.
E chi diceva che la poesia è il rock, la danza ecc. diceva solo una stupidaggine; perché la poesia, in qualche poeta, potrebbe essere anche quello, la danza, ma in effetti, essa, nella sua fase di trasmissione orale, nella sua fase di teatro, è l’individuazione magica di una quintessenza, la sua propria.
Franco Cordelli, Proprietà perduta
Uno dei titoli che avevo pensaro per questa Introduzione era Beppe Salvia e il suo mondo, nel senso che questa espressione ha nella traduzione italiana dell’autobiografia di Isherwood, Christopher e il suo mondo. Considerato in questa accezione, un “mondo” risulta composto di alcuni elementi concreti e verificabili, come una certa epoca storica e un certo luogo, e di altri più opinabili o evanescenti, come le esperienze e gli stati d’animo. Il concetto di “mondo” è sempre più ampio, e meno concettualmente maneggevole, di quelli di “ambiente intellettuale”, “corrente (o tendenza) letteraria” e affìni. Un “mondo”, si potrebbe dire, è tutto e niente nello stesso tempo. Questo tutto e questo niente, nel caso di Salvia, consistono entrambi in Roma. A Roma, a differenza che altrove in Italia, il periodo che va dalla fine degli anni Settanta alla metà del decennio successivo è stato incredibilmente fertile di idee, di sperimentazioni, di illusioni che hanno lasciato tracce in tutte le arti ma che erano anche uno stile di vita, un modo di trascorrere i giorni e le notti. In parole più povere, Roma era una città letteralmente affollata di tipi strani e di anime inquiete, compresa una notevole colonia di forestieri di ogni origine e risma. “Braci” e “Prato pagano”, le due geniali e generose riviste di poesia a cui sempre si associa il nome di Salvia, non sono affatto estranee al quadro generale, non praticano né teorizzano nessuna “separatezza” del genere poetico. I romani di quel periodo, ha scritto Franco Cordelli, prediligono “il regime notturno della psiche” (e per contro “detestano la chiarezza, l’idealismo etereo, l,elevazione”). Ciò comporta sempre un certo grado di indistinzione tra la produzione artistica e l’inflazione emotiva, il prodotto finito e la pratica di vita. E se in quel periodo c’è stata una pratica culturale nella quale tutte queste energie disperse e incontrollabili hanno trovato un punto di convergenza e di nuova esplosione, si tratta sicuramente delle letture pubbliche di poesia. Le parole prima citate di Cordelli provengono da Proprietà perduta, il bellissimo romanzo-reportage-memoriale dei primi due grandi festival internazionali di poesia, che si sono svolti nell’estate del 1979 e in quella del 1980 sulla spiaggia di Castelporziano e a piazza di Siena, nel cuore di Villa Borghese. In molte altre occasioni si era potuto ascoltare anche Salvia leggere i suoi versi, in una maniera che Edoardo Albinati ha ricordato “affannata, a batticuore”, governata da un ritmo implacabile in cui “ogni verso incalza il seguente quasi dandogli la caccia”. Sostiene Cordelli, che è stato non solo lo storico ma anche uno degli ideatori dei primi grandi festival, che affrontando questa avventura teatrale la parola poetica, lungi dal tradire la sua vocazione, semmai, come per magia, si avvicinava proprio alla sua “quintessenza”. Ciò è esatto in due sensi: perché questa rivelazione non riguarda solo il pubblico, che ascoltando la poesia dalla viva voce dei poeti ne scopre dimensioni inedite sia formali che di senso, ma coinvolge i poeti stessi. Il fenomeno è troppo macroscopico per essere relegato a una pura circostanza, o a una moda passeggera. Letture pubbliche di poesia, più o meno seguite da un vasto pubblico, ci sono sempre state e sempre ci saranno; ma accade solo in determinati ed imprevedibili momenti storici che i poeti, servendosi del crogiolo dell’oralità, siano indotti a sperimentare nuove soluzioni espressive, a saggiare la resistenza del mezzo, a verificare limiti e possibilità. È un fenomeno che, in tempi relativamente vicini al periodo che qui ci interessa, influenzò radicalmente la più importante poesia americana degli anni Sessanta, e non a caso furono Allen Ginsberg, William Burroughs, Gregory Corso ed altre stelle del firmamento beat le presenze più memorabili e dotate di un’autentica “aura” al festival di Castel porziano. E mi chiedo se Salvia, l’anno successivo, faceva parte delle poche decine di appassionati che attesero fin dopo mezzanotte, a piazza di Siena, l’altrettanto memorabile performance di Iosif Brodskij. Si potrebbe obiettare che, per quanto celebri e in alcuni casi quasi “mitologici”, eventi come i festival di poesia passano, e a rimanere c’è solo la pagina scritta con i suoi solitari lettori. Ma proprio qui sta il punto: perché, leggendo un poeta come Salvia, così colto e consapevole, ci rendiamo spesso conto che la sua lingua, a un primo sguardo così “scritta” e intessuta di parole desuete, è tutta pervasa dal desiderio di una pronuncia, e non espelle mai totalmenre da sé quella che Roland Barthes chiama la grana della voce.
È assente in Salvia ogni tensione verso l’oltre: la finitezza del mondo non è intesa come disvalore ma vi è un’accettazione della realtà così come essa si presenta: una compresenza di situazioni tra loro slegate, ossia che non fanno senso, che coesistono senza che si cerchino le spiegazioni delle loro relazioni reciproche.
Mario Benedetti
Di un “mondo”, ovviamente, si potrebbe parlare all’infinito. Senza però mai dimenticare, pena la caduta nell’aneddoto e nel pettegolezzo, che nel caso di Salvia tra sé e l’altro da sé esiste sempre il diaframma del narcisismo. Non credo che sia ai nostri fini interessante stabilire se dobbiamo intendere questo narcisismo come una patologia, o invece come una superiore forma di veggenza. Probabilmente, entrambi questi giudizi sono veri ed incompleti. Quello che ci interessa, evocando il narcisismo, non è ad ogni modo una diagnosi psicologica di Salvia, ma un principio poetico di rappresentazione del mondo. In Cuore (cieli celesti), il capolavoro di Salvia uscito a cura degli amici nel 1988, in effetti il narcisismo non ci appare come un’affezione o un ostacolo interiore, ma come un elemento propulsivo della scrittura, uno stile nel senso più ampio e profondo. Ricorro ancora al saggio di Jakobson prima citato, quando osserva che Majakovskij “sente direttamente solo se stesso”. Il fertile paradosso del narcisista consiste nel fatto che, pur rimanendo vincolato a una specie di irrinunciabile e sostanziale solitudine, ancora più del carattere estroverso egli è capace di conoscere in modo penetrante ciò che lo circonda, e di farsene carico come testimone degno di una fede assoluta. Con i suoi studi saltuari e rapidamente abbandonati, la mancanza di un lavoro stabile e molto spesso di un lavoro tout court, i cambi d’indirizzo e un’inquietudine spinta ai limiti del nomadismo, Salvia incarna un’irregolarità di fondo della vita da vero figlio del suo tempo. È una constatazione che non sottrae nulla, sul piano psicologico, all’originalità individuale. Semmai, bisogna notare che si può essere figli del proprio tempo e nello stesso tempo individui assolutamente originali e irripetibili. Ma la cosa più importante, per quello che ci riguarda, è che questa doppia verità ha un rilievo poetico non trascurabile ed è fondamentale, a mio parere, per comprendere il capolavoro di Salvia. In questa grande autobiografia in versi, summa e geroglifico di un’intera esistenza, l’io poetico ci racconta l’unicità del suo destino, non fa altro che rimarcare una distanza tra sé e il mondo. Propriamente parlando, il canto lirico deriva da quello iato, da quell’intervallo fondamentale che la sensibilità individuale oppone all’altro da sé. Ma questa premessa obbligata per ogni moderno (tra i libri preferiti di Salvia hanno un posto di spicco I grandi romantici inglesi di Emilio Cecchi) di quando in quando è smentita o meglio integrata da una coralità che suona altrettanto autentica. Ciò che è unico, non per questo è meno riconoscibile per i lettori. Per impiegare i termini usati da Leopardi nello Zibaldone, nei versi di Salvia assistiamo a una sottile, feconda dialettica del caso particolare e della regola generale. Come quasi mai accade nella poesia, che di solito rifugge inorridita di fronte a questo pronome, il “noi” di Beppe Salvia possiede un’efficacia psicologica quasi pari a quella dell’“io”, non scade mai nella petizione retorica:
Questa è la nostra vita. Questi nostri
volti vagabondi come musi
di cani ci somigliano. Il vento
il sole le corolle rosse e blu,
i sogni mai sognati i nostri sogni.
Questa è la nostra vita e nulla più.
Ogni volta che, in tutti questi anni, ho riletto una poesia di Salvia, mi sono tornati in mente i versi finali dell’Onegin. Beato, scrive Puškin, chi ha lasciato in tempo la festa della vita, congedandosi col giusto anticipo, beato chi non ne ha letto il romanzo fino all’ultima parola. Alla fine di questa Introduzione, registro questi pensieri di Puškin, terribilmente presaghi, come una specie di viatico alla lettura di Salvia – soprattutto a beneficio di chi si accosta per la prima vorta a questo grande poeta. Inevitabilmente, il nuovo lettore si chiederà in che modo Salvia, se non fosse morto a trent’anni, avrebbe continuato a spendere il suo talento: in che direzione, con quali esiti. Potrà anche essere una domanda assurda, ma il bello è che in ogni pagina, anzi in ogni singolo verso di questo libro si potrà trovare una risposta. Ho detto sopra che Salvia, fin da quando era un semplice apprendista confuso in una moltitudine di apprendisti, già si comportava come un classico. Preciserei questo pensiero, al momento di farmi da parte, dicendo che ogni sua parola adesso può apparirci come un’ultima parola. Questo è il senso profondo, mi sembra, dei versi di Puškin. I quali non vogliono certo affermare che è beato chi muore giovane. E perché mai dovrebbe esserlo? La beatitudine, semmai, e in particolare la beatitudine connessa al talento, consiste nel distacco, nella capacità di impegnare tutto il proprio essere nell’opera per poi, una volta che la si è condotta a perfezione, volgerle le spalle, come se si trattasse dell’opera di un altro. È solo così che si è padroni, e non servi, di ciò che si fa – riuscendo ad abbandonare la festa quando ancora è al suo culmine, come suggerisce Puškin: da un lato affrettandone la fine, ma dall’altro facendone durare per sempre la gioia e la bellezza.
(Introduzione a Un solitario amore, antologia, Fandango, 2006)