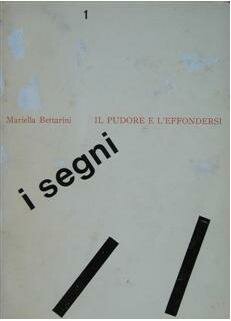ROMA. Borghetto Flaminio è una serie di casette in muratura, poco più che baracche, superfetazioni del dopoguerra, che s’inerpica accanto al nuovo museo del bambino. Lì c’è la casa di Valentino Zeichen. Ci abita da quasi quarant’anni. All’inizio la condivideva con un amico pittore: lui la usava di giorno come studio, Valentino ci dormiva di notte. Pagava un piccolo affitto al proprietario, poi un giorno anche lui è sparito. L’area è del Comune che gli ha ordinato lo sfratto, due anni fa. Sono due ambienti, tre con la cucina: una stanza da pranzo e una camera da letto. Definirle camere è generoso, per via delle dimensioni e poi perché sopra il tetto è di eternit e onduline, mentre il pavimento, coperto di piastrelle recuperate, è privo di vespaio: freddo d’inverno, caldo torrido d’estate. Ma Zeichen, poeta laureato due anni fa con un elegante Oscar Mondadori che ne raccoglie tutta l’opera edita sinora, ci vive in modo molto dignitoso.
ROMA. Borghetto Flaminio è una serie di casette in muratura, poco più che baracche, superfetazioni del dopoguerra, che s’inerpica accanto al nuovo museo del bambino. Lì c’è la casa di Valentino Zeichen. Ci abita da quasi quarant’anni. All’inizio la condivideva con un amico pittore: lui la usava di giorno come studio, Valentino ci dormiva di notte. Pagava un piccolo affitto al proprietario, poi un giorno anche lui è sparito. L’area è del Comune che gli ha ordinato lo sfratto, due anni fa. Sono due ambienti, tre con la cucina: una stanza da pranzo e una camera da letto. Definirle camere è generoso, per via delle dimensioni e poi perché sopra il tetto è di eternit e onduline, mentre il pavimento, coperto di piastrelle recuperate, è privo di vespaio: freddo d’inverno, caldo torrido d’estate. Ma Zeichen, poeta laureato due anni fa con un elegante Oscar Mondadori che ne raccoglie tutta l’opera edita sinora, ci vive in modo molto dignitoso.
Mi fa sedere su una poltroncina vicino alla porta da cui entra un soffio gelido. Ogni tanto si alza e mentre parla va verso la stufa, piccola, consunta, di terracotta annerita, getta un pezzo di legna nel fuoco. In alto un tubo smaltato attraversa la stanza e barattoli pendono sotto le giunture: puro De Sica di Miracolo a Milano. Ma qui siamo a Roma e Valentino Zeichen, cantore della Città Eterna in Ogni cosa a ogni cosa ha detto addio (Fazi), vive la maggior parte del suo tempo in giro per la città. La leggenda vuole che sia sempre invitato, pranzo e cena, da amici, semplici conoscenti o persone sconosciute, anfitrioni che lo vogliono alla loro tavola, lui, intrattenitore nato, parlatore instancabile, colto e affabulante, appena uscito da una pagina del Satyricon.
Quando è arrivato qui? «La mia famiglia è dell’Istria. Siamo adriatici dalmati. Mio padre era giardiniere ad Abbazia, vicino a Fiume. Siamo andati via dopo la guerra, perdendo tutto. Prima a Parma, dove eravamo trattati con ostilità perché stranieri, poi qui, a Roma, nel 1950. Mio padre ha trovato una vecchia stalla a Villa Borghese e l’ha riadattata. Mia madre era già morta da tempo e mio padre si è risposato. Faceva fatica a starmi dietro. Ero inquieto, instabile, scappavo sempre. Sono stato tre anni a Firenze in una casa di rieducazione. Lì ho studiato un po’, chimica, ma soprattutto leggevo. La biblioteca del reclusorio aveva tanti libri. Li divoravo».
Sul nome di Zeichen – in tedesco significa «segno» – aleggia un mistero. In una antologia poetica Giorgio Manacorda ha scritto due anni fa che il suo vero nome è Giuseppe Mario Moses, cognome quasi sicuramente ebreo. Gli chiedo se è vero. «No, sono delle fantasie». Più volte durante il colloquio, e anche dopo, a pranzo – ci prepara un’ottima pasta col sugo di pomodoro, quando arriva il critico Andrea Cortellessa -, gli chiedo di mostrarmi un documento. Fa spallucce, sorride e dice di non sapere dove sia finito. Zeichen è un bellissimo uomo di quasi settant’anni (è nato nel 1938, ma anche questo è un dato incerto), apparentemente duro nei comportamenti – vuole dare di sé un’immagine di cattivo, o almeno di non-buono – è invece, sotto sotto, dolce, come la sua poesia, che possiede movenze arrotondate, fluide, e smussa le asprezze del dire attraverso una grazia sottile.
Quanto i libri le sono stato utili nella vita? «Molto. Volevo saperne più degli altri, leggevo di continuo. Non ho completato nessuna scuola: iniziavo sempre qualcosa di nuovo e poi lo interrompevo. Solo l’Accademia Scharov, una scuola di recitazione. Volevo fare l’attore». In effetti Zeichen sembra impostato nei gesti e nella voce. E tuttavia possiede una sua naturalità. Era inquieto? «Sì, come tutti i giovani. Ho viaggiato molto in autostop, Francia, Germania. Lavavo i piatti nei ristoranti, ho fatto il tipografo, raccoglievo le mele».
(di Marco Belpoliti su La Stampa)